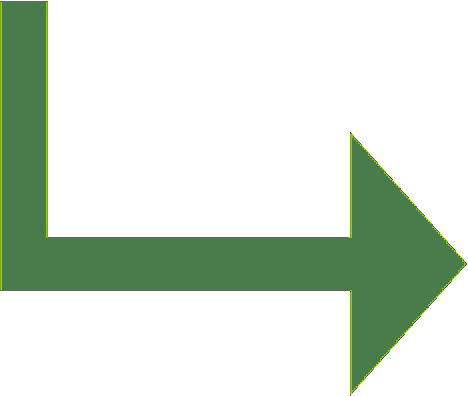Quando
ero bambina c’era la mamma, il papà e la Ia. La Ia era la mia tata. Ovviamente
questo non era il suo vero nome, ma quello che le avevo affibbiato io che,
troppo piccola per poter pronunciare la parola “Signorina”, l’avevo
abbreviata in Ia. Fu assunta dai miei genitori quando io e i mio fratello
eravamo piccolissimi. Ha visto mio fratello minore nascere. Ci ha tirati su. Ha
smesso di lavorare per la mia famiglia solo quando i miei genitori si sono
separati e hanno chiuso la casa dove abbiamo sempre abitato. Avevo ormai 32
anni. Ho continuato a fare visita alla Ia fino a quando non è morta, due anni
fa, a 84 anni. In tutti questi anni non credo di aver mai saputo bene chi fosse
questa donna che ha trascorso e offerto la sua vita, insieme al sacrificio del
suo nome proprio, a me, ai miei fratelli e ai miei genitori. Non serviva. Lei
era vera, reale, in quanto la mia tata. Al di là di questo nient'altro sembrava necessario. In casa nostra, in quella che è stata anche la sua casa per più di
trenta anni, aveva la sua camera, tenuta come una piccola sagrestia.
Ordinatissima, piena di immaginette religiose e di foto di famiglia, questo era
l’unico luogo dove la Ia tornava Anna e per questo difeso fermamente contro i
nostri tentativi di forzare uno spazio per lei sacro. Non credo che la camera
di Vivian Maier fosse così ordinata, ma penso che con la mia Ia abbia condiviso
lo stesso bisogno di segretezza per arginare una vita alla mercé degli altri.
Quando
ero bambina c’era la mamma, il papà e la Ia. La Ia era la mia tata. Ovviamente
questo non era il suo vero nome, ma quello che le avevo affibbiato io che,
troppo piccola per poter pronunciare la parola “Signorina”, l’avevo
abbreviata in Ia. Fu assunta dai miei genitori quando io e i mio fratello
eravamo piccolissimi. Ha visto mio fratello minore nascere. Ci ha tirati su. Ha
smesso di lavorare per la mia famiglia solo quando i miei genitori si sono
separati e hanno chiuso la casa dove abbiamo sempre abitato. Avevo ormai 32
anni. Ho continuato a fare visita alla Ia fino a quando non è morta, due anni
fa, a 84 anni. In tutti questi anni non credo di aver mai saputo bene chi fosse
questa donna che ha trascorso e offerto la sua vita, insieme al sacrificio del
suo nome proprio, a me, ai miei fratelli e ai miei genitori. Non serviva. Lei
era vera, reale, in quanto la mia tata. Al di là di questo nient'altro sembrava necessario. In casa nostra, in quella che è stata anche la sua casa per più di
trenta anni, aveva la sua camera, tenuta come una piccola sagrestia.
Ordinatissima, piena di immaginette religiose e di foto di famiglia, questo era
l’unico luogo dove la Ia tornava Anna e per questo difeso fermamente contro i
nostri tentativi di forzare uno spazio per lei sacro. Non credo che la camera
di Vivian Maier fosse così ordinata, ma penso che con la mia Ia abbia condiviso
lo stesso bisogno di segretezza per arginare una vita alla mercé degli altri.
Vivian
Maier è la protagonista di un documentario, “Alla ricerca di Vivian Maier”, di
John Maloof e Charlie Siskel distribuito da Feltrinelli Real Cinema. Vivian era
una tata. Per 40 anni ha tenuto bambini altrui, vissuto in case altrui, abitato
letti altrui. E fatto foto. Per decenni la Maier ha scattato più di centomila
foto, girato centinaia di filmini, inciso decine di audiocassette e accumulato
giornali e quotidiani in pile altissime e pesanti che finivano per incassare il
parquet della sua stanza. Ma durante la sua lunga vita (la Maier è morta nel
2009 a 83 anni) non ha mai pubblicato e spesso neanche sviluppato un solo
negativo.
Dall’alto
del suo metro e ottanta di altezza questa donna dal grande naso, che sembra
uscire da un film di Jacques Tati (sua madre era francese e lei stessa ha
trascorso lunghi anni della sua infanzia in un paesino sperso nelle montagne
savoiarde), ha percorso chilometri di strada con comode scarpe piatte, larghi
cappottoni e berretti dall’ampia falda riprendendo con l’onnipresente
Rolleiflex al collo tutto ciò che vedeva per strada - vecchie signore
impellicciate, bambini piangenti, barboni sul ciglio della strada, animali
morti, vecchie bambole buttate nel cestino – tutte immagini che non avrebbero
mai visto la luce se non fosse stato per un caso fortuito. Nel 2007 a un’asta
John Maloof entrò in possesso di alcuni dei suoi rullini e da allora, con una
determinazione ammirevole, è riuscito a recuperare la maggior parte del
materiale della Maier, che oggi è considerata una delle grandi fotografe del '900 con mostre in tutto il mondo.
Negli anni Maloof ha ritrovato anche centinaia di
altri scatoloni nei quali la Maier aveva accumulato nel tempo i suoi effetti
personali. Una moltitudine di oggetti che nel corso della sua vita hanno significato
qualcosa per lei e che ha forse conservato per creare come Pollicino, una
sorta di sentiero segreto,
visibile solo a occhi esperti e desiderosi di raggiungere una zona molto vicina al suo
cuore e alle sue emozioni più profonde. Ma non successe mai. A
una signora che una volta le chiese cosa facesse nella vita, Vivian Maier
rispose che era una spia. Certo,
con la sua macchina fotografica la Maier spiava persone, cose e animali. Ma
soprattutto, come una spia, la Maier conduceva una doppia vita: una socialmente
accettata, visibile, contornata da bambini e dalle famiglie di questi. E poi
c’era l’altra vita. Quella di una donna solitaria, eccentrica al limite
dell’alienazione, che ha fatto fotografie bellissime, profondamente empatiche
verso un mondo che riusciva a leggere con incredibile lucidità. Nella sua solitudine, oltre alle foto di strada, la Maier ha anche scattato decine di
autoritratti, quasi nel tentativo di ridisegnare la sua identità al di fuori di
quella ordinatamente offerta a coloro che la ospitavano.
Io
credo che il senso di questo film sia soprattutto di quanto sia impossibile
conoscere la reale essenza di una persona, di quanto sia difficile per tutti
noi entrare davvero in contatto con i nostri simili e come, al tempo stesso,
questo imponente desiderio di mostrarci agli altri per come siamo veramente e
metterli a parte del nostro mondo interiore sia la cosa che più di ogni altra
ci tiene su questa Terra e ci fa andare avanti con l’esistenza che ci è data.